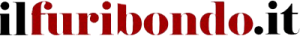Esodo è una parola grande, antica, impegnativa. C’è un Esodo – quello in cui Mosè tira fuori un popolo dalla schiavitù d’Egitto – che sintetizza forse la memoria collettiva dell’Occidente rispetto al rapporto tra oppressione e liberazione. Dentro quell’esodo si agitano migliaia e migliaia di altri esodi, personali e sociali, di cui solo alcuni sono stati scritti e ricordati dalla storia. Storia che, luogo comune-ma mica tanto, viene scritta dai vincitori: rimangono dunque nell’ombra tutti quegli esodi degli sconfitti, di cui oggi – e solo ogni tanto – cogliamo lampi e baluginii grazie all’onda dei migranti sul Mediterraneo.
Ormai più frequentemente associata al traffico autostradale durante le ferie d’Agosto, abbiamo dimenticato che la parola esodo è, prima di tutto, azione di un sistema oppressivo, di un potere che fa solo schiavi e vittime, a cui segue uno scatto di coscienza: la consapevolezza che solo l’uscita da quel luogo/da quella condizione può chiamarsi libertà. Interrogarsi sulle dinamiche che generano oppressione e schiavitù, e che quindi determinano la fuga, è un esercizio che facciamo troppo poco, bofonchiando solo parole bisillabe o trisillabe: fame, guerra, sete, povertà… Attribuiamo ad una forza soprannaturale l’azione oppressiva, con la novità che la religione del consumismo ha sostituito Dio con le Multinazionali, artefici di vita e morte sopra e sotto la linea dell’Equatore. Declinato poi nelle sue varie correnti eretiche, questo politeismo finanziario è l’origine di tutti i mali, per cui valgono, ovviamente, professioni di fede o di abiura.
Ma se c’è una cosa che il grande esodo dall’Egitto dovrebbe rammentare è che la liberazione chiama alla responsabilità sia chi opprime sia chi è oppresso. Nel racconto biblico tanto il Faraone quanto Mosè riflettono su se stessi e sulle conseguenze dei propri gesti. A farla breve e semplice: l’Esodo provoca una riflessione sia nel padrone che nello schiavo.
Non ci sarebbe bisogno di aggiungere che, a leggere gli esodi di oggi, non c’è una volta in cui il potere ragioni su se stesso. In questo senso è illuminante vivere alla punta bassa d’Italia, passare una vita a salutare chi parte per cercare libertà e fortuna, avvolti dalla retorica del “basta con i cervelli in fuga”, “ è ora che i calabresi possano vivere felici anche in Calabria”… Frasi pronunciate, negli anni, dalle peggiori – o giù di lì – classi politiche e dirigenziali che l’umanità rammenti: conseguenza, peraltro, del peggiore popolo di elettori che la democrazia possa annoverare. L’esodo di Calabria è uno stillicidio lento e inesorabile, fatto anche di ritorni e ripartenze, legato ad un contesto comunque e sempre difficile. Un microcosmo che rappresenta, in sintesi, quanto avviene su scala più grande e ad altre latitudini: povertà materiale o culturale – impossibilità a realizzare una vita pienamente libera – partenza o fuga. Anche senza guerre evidenti e senza carestia, la Calabria è rappresentativa di un modello culturale ed economico opprimente, destinato a frustrare le aspirazioni di chi ci vive o ad alimentare il desiderio di allontanarsene. Da qualche tempo si guarda a questo destino di esodo con la rassegnazione dell’ineluttabile, parcellizzazione di un Paese Italia che ha poco da offrire. Ma quello di Calabria è un esodo più antico e duraturo: permanente. Resiste integro il narcisismo demagogico della politica, che promette e rivive primavere senza che i cittadini se ne accorgano; un viaggio tra due fuochi: quelli che “questa è la terra della Magnagrecia, non bisogna parlane male e chi lo fa è un ingrato e un nemico” e quelli che “ via da qui, a passo svelto”.
Noi, che qui scriviamo, non apparteniamo a nessuna di queste due categorie. Scriviamo per incontrare lo stato d’animo di altri come noi, ma anche per indignazione ostinata. Raccontare l’esodo dal nostro parallelo trentotto è un modo per leggere, da angolatura privilegiata, quel che avviene in Italia e più oltre. Una periferia sociale e culturale che tutte le periferie racconta.
Narrare l’esodo significa però anche riconvocare alla responsabilità chi è andato e chi è rimasto: la memoria delle due differenti scelte – e delle ragioni da cui scaturiscono –
è l’unica denuncia utile, è la sola medicina per una terra senza memoria.