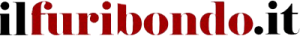di Romina Arena –
(foto di Marco Costantino)
La città è la vacca grassa, feconda. La vacca munifica. Mammelle gonfie cui aggrapparsi per succhiare oltre la sazietà. E’ stato approdo per il progresso, miraggio per le campagne, nuova dimensione del futuro nel benessere e nella ricchezza. Centro per gli affari, gli scambi, i commerci e così si è sviluppata, nei secoli, approfondendo la sua identità, personificandosi nel luogo in cui c’è tutto. Dove non manca niente. La città è un concetto vasto, disarticolato come vasta e disarticolata è la sua espansione. Dal mare alle colline non c’è spazio che resista dall’essere fagocitato, antropizzato. Un’occupazione costante e continuativa senza rimedio apparente, senza sosta che tenga. Come Leonia – la città invisibile di Italo Calvino – “ogni anno la città s’espande, e gli immondezzai devono arretrare più lontano; l’imponenza del gettito aumenta e le cataste s’innalzano, si stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto […] Il risultato è questo: che più Leonia espelle roba più ne accumula; le squame del suo passato si saldano in una corazza che non si può togliere; rinnovandosi ogni giorno la città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle spazzature d’ieri che s’ammucchiano sulle spazzature dell’altroieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri”. La città cresce su se stessa e dentro se stessa, è il respiro di molte anime, il nucleo centrale in cui succedono le cose. Per questa ragione non sfugge al fiuto predatorio degli speculatori, dei palazzinari, dei truffatori di ogni risma. Non sfugge all’intuito delle criminalità che in essa – spostatisi dalle campagne, dalle guardianie, dagli uliveti e dalle greggi – trovano la loro nuova dimensione di profitto. La città è il centro di potere politico ed economico in cui si giocano le partite cruciali, un crogiolo di soldi ed interessi, ammanicamenti e truffe. Il cuore pulsante della corruzione, il vertice alto del malaffare.
A Reggio Calabria, per rendersi conto di come funzionano certe cose, non servono studi scientifici, saggi di prezzolati accademici, speculazioni intellettuali. Basta buttare un occhio in giro. Basta guardarsi con attenzione attorno. Basta vedere come si è sviluppata la città. Dagli anni Ottanta in poi si costruisce ovunque, verso l’alto (Arangea e Gallina), verso sud (Pellaro), verso nord (Catona); in riva al mare, sul greto delle fiumare e nei loro alvei ormai prosciugati, sui costoni franosi. La movimentazione terra è un affare ciclopico che mette in moto interessi trasversali. L’impero si allarga e fagocita tutto sotto spettrali colate di cemento, ferri conficcati contro il cielo. Un risultato impossibile se dietro le cosche non ci fosse stata una fitta rete di architetti compiacenti, falsi geologi, funzionari, impiegati comunali, urbanisti che con le coperture istituzionali, la concessione di permessi edilizi, la falsificazione delle carte, i condoni ha permesso la perpetuazione di pratiche criminogene. Una bolla, quella dell’edilizia e dell’urbanistica, che scoppia negli anni Novanta, quando a guidare il comune di Reggio Calabria c’è un giovane e rampante democristiano, Agatino Licandro, travolto dallo scandalo che porta il nome di “Tangentopoli reggina” e condannato per falso ed abuso in atti d’ufficio. Una storia torbida in una città che non si è mai ripresa da quella stagione raccontata con lucidità dallo stesso Agatino Licandro e dal giornalista Aldo Varano in La città dolente (Einaudi, 1992). Ma Reggio Calabria non è tutto. Non può esserlo, se crediamo alla globalizzazione dei fenomeni. C’era un tempo, infatti, in cui si credeva che la mafia fosse una questione puramente meridionale, che appartenesse agli archetipi culturali ed antropologici dei pastori del sud. Però i tempi mutano, il crimine si evolve e si raffina. Scalando i vertici, facendo i soldi, finisce prima o poi per bussare anche alle porte delle grandi metropoli. Succede così anche a Milano, anzi soprattutto a Milano e nelle sue zone limitrofe dove approdano le cosche calabresi a reinvestire i soldi dei riscatti – racimolati durante la stagione dei sequestri – ed impiantare la loro nuova economia fatta di mattone. Fanno quello che gli riesce meglio: intrallazzare e costruire grossi imperi su questi intrallazzi. Monopolizzano il movimento terra, hanno il controllo assoluto dell’ortomercato e sono i padroni incontrastati del traffico di cocaina. Così, senza che nessuno glielo impedisca, la ‘ndrangheta della Calabria – i Pelle, i Morabito, i Serraino – si è fatta padrona e signora della Milano da bere, della Milano dei grossi capitali, del lavoro, della moda e dello sviluppo. Le mani sulla città (Chiarelettere, 2011), il ricchissimo ed articolato saggio di Gianni Barbacetto e Davide Milosa, incrociando dati, inchieste, testimonianze e dietro un certosino lavoro di ricostruzione, mette nero su bianco come sia stato possibile tutto questo.
Se c’è un crimine, però, ci deve essere anche un humus del quale esso si nutre. Una mentalità che si costruisce e che si radica nel tempo. Franco Musolino e Pasquale Romeo – uno prefetto l’altro psichiatra, intervistati da un fantomatico John Doe scippato al gergo giuridico statunitense ed equiparabile al nostro NN – nel loro saggio L’area grigia (Città del Sole, 2010) provano a dipanare la fitta matassa concettuale che aggroviglia la relazione tra ‘ndrangheta e società civile. Una deriva che parte dalle istituzioni ed approda al fatalismo nudo e crudo, l’immobilismo lampante e senza via di fuga apparente, al clientelismo ed alla cultura del favore imperniata nel culto obbligato della famiglia. Qui, in questa crepa della società, in questa terra di nessuno governata dall’incapacità comunicativa tra i cittadini e le istituzioni, in cui è facile suscitare malumori e lamenti salvo aborrire poi la protesta come forma di riappropriazione dei propri diritti ed ignorare l’opzione di una buona amministrazione, nasce la cosiddetta “area grigia”. Uno spazio intermedio tra legale ed illegale in cui è difficile mettere a fuoco bene ogni cosa, in cui tutto è sfumato ed assume contorni poco nitidi. La zona grigia fa il suo nido dove tutto è più confuso, dove i ruoli sono indistinti, dove la clientela è più semplice da acquisire, dove è infinitamente più facile raggiungere lo scopo per vie traverse e con metodi meno ufficiali. In un contesto così liquido tutto è ‘ndrangheta, perché ogni cosa ne è permeata; dai cantieri agli uffici pubblici. Niente è ‘ndrangheta perché l’immanenza la rende evanescente: talmente dentro le cose da assumerne le sembianze. Come dire che il trucco c’è ma non si vede, senza nemmeno il conforto dell’illusione. Ma questa farcitura esplosiva non è altro che un fenomeno endogeno alla società, un verme che divora da dentro e che trova il suo habitat perfetto nel lassismo sociale, nella cultura del sotterfugio e dell’espediente, nell’incapacità del cittadino di rifiutare certe declinazioni della mentalità mafiosa.