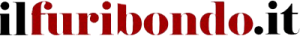di Romina Arena –
Umberto Eco scriveva che l’Italia è una Repubblica fondata sui puntini sospensivi. Di fatto, del proposito esortativo, nobilitante, ricco di dignità di quell’articolo uno in cui i padri costituenti racchiusero le due colonne portanti suggerite dai comunisti – i lavoratori del braccio e della mente – nulla è rimasto, oggi. O ben poco. Sciolto e dissolto in una politica del lavoro che ha svenduto gran parte dei principi in cui quell’articolo metteva radici e delle conquiste ottenute con la lotta dai nostri padri e dalle nostre madri. Di quelle battaglie, oggi, è rimasto un corpo morto, un apparato che piano piano torna indietro, che cerca capestri contrattuali per imbrigliare i lavoratori, che li priva di voce e, troppo spesso, di dignità. Il lavoro è qualcosa di indefinito, incerto, sospeso. Proprio come i puntini di Eco. Per quei giovani che sono alla ricerca di un’occupazione, è mandare curricula il vero lavoro a tempo indeterminato. Il lavoro nobilita, certo, significa che non vai a rubare, che non sei un parassita. Ma quando significa spaccarsi la schiena a raccogliere pomodori in Puglia o arance a Rosarno; quando significa stare su un’impalcatura senza protezione e in nero; quando significa firmare contratti fasulli o ritrovarsi in busta paga meno di quanto è dichiarato; quando sei donna e non puoi diventare madre e non puoi fare carriera perché o i figli o il posto, anche in questi casi il lavoro nobilita?
In Gli africani salveranno Rosarno (Terrelibere, 2011), Antonello Mangano ci racconta un pò di storie sui migranti che si ritrovano a lavorare nella Piana di Gioia Tauro, in Calabria, a raccogliere agrumi per un pugno di spiccioli in un contesto economico e sociale abominevole fatto di ‘ndrangheta e ottusità culturale, modernità rampanti ed arcaismi innati. Un esempio analogo di caporalato e sfruttamento massificato ce lo dà Alessandro Leogrande, con Uomini e caporali (Mondadori, 2008), nel quale ci racconta le storie di quanti, in estate, si riversano nel Tavoliere delle Puglie per la raccolta dei pomodori. Un quadro d’insieme, invece, lo danno Yvan Sagnet e Leonardo Palmisano in Ghetto Italia (Fandango, 2015). Un filo unico accomuna la Calabria, la Puglia, la Campania, la Basilicata: i lavoratori africani o dell’Est europeo sfruttati come bestie, che abitano casolari fatiscenti privi di ogni cosa – che sia acqua, luce e, di conseguenza, igiene. Invisibili, come le badanti rumene che accudiscono i nostri anziani, le colf filippine che puliscono le nostre case, i pastori Sikh che badano i nostri armenti, le lavoratrici cinesi che cuciono i nostri vestiti. Cosa succederebbe se di punto in bianco sparissero tutti? Provate ad immaginare il caos, la paralisi: industrie manifatturiere bloccate, pomodori e arance lasciati marcire sui campi e sugli alberi, cantieri edili fermi. Per non parlare delle nostre case e dei nostri vecchi. O leggete Blacks out (Laterza, 2010) di Vladimiro Polchi, a metà tra fiction e new realism, su cosa potrebbe succedere se tutti i lavoratori del sommerso un giorno decidessero di averne abbastanza.
Invisibili e precari, ecco come sono i lavoratori oggi. Giovani neolaureati di belle speranze che per continuare a coltivare il loro sogno, bene che gli vada, devono espatriare. L’Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani ha curato a proposito un volumetto Cervelli in fuga. Storie di menti italiane fuggite all’estero (Avverbi, 2001) in cui si ripercorrono storie di fratture ma anche di successi di venti giovani ricercatori che per fare il loro mestiere sono dovuti andare via dall’Italia. Una pesante accusa al sistema baronale delle Università italiane ed una spietata denuncia ad un a politica avara e cieca quando si tratta di finanziare ricerca e cultura. Male che gli vada, invece, restano qui ad infoltire le fila di quanti si prendono i nostri insulti chiamandoci al telefono a tutte le ore del giorno. Precari, in bilico su contratti beffa che durano a volte, nella più grottesca delle farse, anche un giorno solo. L’opera collettanea Tu quando scadi (Manni, 2005), è una summa ironica, ma molto amara delle testimonianze dirette di alcuni di essi che raccontano i retroscena delle loro condizioni di lavoro e delle loro situazioni contrattuali. Un labirinto asfittico con pareti sempre più strette ed aria sempre più rarefatta.
Nel 1955 Ernesto Rossi – intellettuale di raro spessore, antifascista confinato a Ventotene con Altiero Spinelli – pubblicò I padroni del vapore (ripubblicato da Kaos, 2001), nel quale metteva nero su bianco la spietatezza della politica economica messa in piedi dal fascismo durante il Ventennio con la connivenza di Confindustria. In esso puntava l’indice contro i padroni del vapore, coccolati ed assecondati nei loro capricci da un regime che aveva vitale bisogno dei loro capitali. Ernesto Rossi, che per lingua lunga non era secondo a nessuno, sferzava con la penna un sistema diabolico che esaltava l’ iniziativa privata intesa come un lasciare briglia sciolta ai grandi finanzieri, i padroni del vapore, appunto; ammetteva senza vergogna che il carico più oneroso delle imposte si spostasse dai ceti più ricchi a quelli più poveri; propugnava il superamento della lotta di classe col sindacalismo schiavista. In mezzo, implicitamente, c’era tutta una massa di lavoratori sfruttati che subivano l’abominio di una politica economica così condiscendente coi rampanti capitani d’industria e così miope verso tutto il resto.
Marx a suo tempo, riflettendo su un principio già espresso da Hegel, disse: “Sembra che tutto si presenti due volte, una come tragedia e una come farsa”.