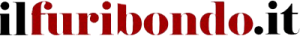*
Chi augura ad un essere umano di marcire in galera non sa cosa significhi passare anche un’ora dentro un istituto penitenziario. Figurarsi la consapevolezza acquisita giorno per giorno e ogni giorno vomitata addosso dalle mura, dalle sbarre, dagli assistenti frustrati da un sistema che rende eccezionali le esigenze più banali e difficili le operazioni più semplici, di doverci passare tutta la vita. Non serve augurare di marcirci, in galera, perché ogni detenuto lo sa già da sé che è esattamente quello che succede, giorno per giorno. Marcire. Il sistema penitenziario nazionale è sclerotizzato dalle inefficienze, dalle carenze, dalla disumanità. Non serve che un Ministro dello Stato lo auguri spettacolarizzando pro domo sua un arresto eccellente. Ogni detenuto, ogni anonimo detenuto, nel fondo della sua cella lo sa, lo vive sulla propria pelle che la galera è la discarica sociale di un Paese incapace di una parola matura sulla colpa e sul perdono. Perché è questo il punto: che cos’è la colpa e che cos’è il perdono. Che cos’è la giustizia e che cos’è, invece, la vendetta. Se, oltre che nella pena da scontare, la colpa è pagata in una quotidiana umiliazione e nella mortificazione della propria dignità; se, come scriveva Ungaretti, la morte si sconta vivendo, allora non è possibile ragionare sul perdono. Se è la forza che determina il diritto, allora non c’è posto per l’amore in questo mondo, dice Padre Gabriel in Mission.
Sono pochi i fortunati che scontano la condanna in penitenziari modello, quelli in cui esistono attività di recupero e reinserimento che offrono veramente una alternativa e, dentro l’alternativa, la possibilità di intraprendere un percorso umano di riconsiderazione di sé, di riscatto, di dignità. Sono pochi i fortunati a cui la galera apre un varco, l’opportunità di rientrare nel tessuto sociale. Pochi quelli a cui insegna un mestiere, pochi quelli che ritornano liberi al mondo con qualcosa tra le mani da poter spendere. Per tutti gli altri non è così. Per tutti quelli che hanno la sfortuna di capitare in penitenziari gestiti con miopia, strafottenza, manie da piccolo impero la galera è la stagione del tempo sospeso a tempo indeterminato. Pochi mesi, pochi anni. Per sempre. Un tempo di abbandono in cui la scuola è una conquista e fare il passavitto, il piantone, l’uomo delle pulizie o lavorare nelle cucine è il massimo dell’aspirazione e tutto quello che il carcere è in grado di offrire. Forse servirebbe farsi una domanda banale, di quelle che costano poco: come passa la sua giornata il detenuto di un carcere ordinario, cioè il detenuto di un carcere che non offre nulla se non piccole attività gestite su base volontaria da donne e uomini di buona volontà che decidono di dedicare un pezzo della loro vita a visitare i carcerati? Come riempie il tempo il detenuto di un carcere che non è capace di aprire corsi, attività professionalizzanti; che non è in grado di porsi la questione del recupero e della riabilitazione; che vivacchia pensando che l’ora d’aria e la partita a dama siano sufficienti a riempire la giornata; il cui unico scopo è “tenerli buoni”?
Chi dice che si debba marcire in galera non sa di cosa parla. Non ha mai visto un detenuto, non è mai stato con lui, parlato con lui, non sa cosa provi, come viva, quanta frustrazione accumuli nella sua giornata. Non lo vede ingobbirsi su se stesso di settimana in settimana, perdere una fluidità di linguaggio già faticosa, ottundersi, abbrutirsi. Non lo vede lo sguardo spegnersi e con esso la speranza di non essere considerato un rifiuto, di quelli più inutili che non si può fare altro che gettare nella raccolta indifferenziata. Chi dice che si debba marcire in carcere non sa che questo già succede e che è abominevole. In galera si muore e il tasso di suicidi è altissimo. Nel 2018, su 148 decessi, 62 sono stati suicidi. La vita può contare tanto o contare niente e non importa l’età, la gioventù o la maturità, la solidità dell’animo o la prontezza dello spirito perché dietro un muro si diventa tutti vecchi all’improvviso. “Io passo tutta la settimana solo per viverne tre ore”, dice A., gli occhi sempre più assenti e la sensazione di essere diventato inutile. “Fuori progettavo di tutto, qui dentro non riesco fare niente. Ci provo ma non ci riesco”. E’ la noia, l’apatia, la percezione che lì dentro nulla abbia senso, che non valga la pena impegnarsi in qualcosa.
E’ anche, soprattutto, una questione di spazio. Il carcere, per definizione, limita la libertà di movimento e spostamento; una cella, la tumula. Jonathan Safran Foer nel 2010 scrisse un libro che nel suo genere è diventato un cult: Se niente importa. Parlando di allevamenti avicoli, dice: “E’ antropomorfismo immergersi nella gabbia di un animale d’allevamento? […] una gabbia per galline ovaiole concede in genere a ogni animale una superficie all’incirca […] grande poco meno di un foglio A4 […] Entra mentalmente in un ascensore affollato, un ascensore così affollato che non riesci a girarti senza sbattere (esasperandolo) contro il tuo vicino. Un ascensore così affollato che spesso rimani sollevato a mezz’aria. […] Dopo un po’ quelli che stanno nell’ascensore perderanno la capacità di lavorare nell’interesse del gruppo. Alcuni diventeranno violenti, altri impazziranno. […]Non c’è tregua, non c’è sollievo. Non arriverà nessun addetto a riparare l’ascensore”. Ad oggi, le condizioni di vivibilità interna ai penitenziari italiani non sono lontane dal quadro fosco e oggettivo illustrato da Safran Foer. C’è poco da biasimare lo scoraggiamento e la sfiducia in luoghi che intaccano la possibilità di condurre uno stile di vita adeguato a partire dal soddisfacimento dei bisogni primari e del diritto all’affettività e alla salute. Luoghi in perenne sovraffollamento; con gravi carenze di salubrità e igiene; forni d’estate, ghiacciaie in inverno; che patiscono croniche carenze di spazi o, nel paradosso opposto, sono incapaci di sfruttarne il potenziale; che non ne destinano di adeguati alle attività trattamentali, alla libertà di culto, alle attività sportive. Sarebbe utile, per approfondire tutti questi aspetti, leggere con attenzione Un anno in carcere – XIV rapporto sulle condizioni di detenzione, a cura di Associazione Antigone. Non c’è da stupirsi di questo e di niente altro in un ambiente che fa dell’incomunicabilità l’ostacolo al confronto, l’arma invincibile per fingere di non capirsi e di non capire ventilando questioni di sicurezza. Non è solo questione di sicurezza. Spesso, troppe volte è anche questione di ottusità. In posti così c’è solo una infinità di spazio e di tempo per rimpiangere la vecchia vita piuttosto che desiderare di ricostruirne una nuova. Non è un caso – non è per niente, scriveva Clemente Rèbora in una sua poesia – che le percentuali di recidiva non accennano a diminuire. A che cosa serve un carcere così e a chi? A niente. A nessuno. Il carcere è addestrato per uccidere i sogni, scrive Carmelo Musumeci, detenuto all’ergastolo ostativo.
Siamo un Paese sciatto e distratto che si guarda l’ombelico sorpreso che si tratti di un buco. Ogni volta sorpreso che si tratti di un buco. Siamo un Paese cialtrone e ignorante che si accontenta della prima scusa se a darla è chi cambia giacca come cambia palcoscenico. Siamo un Paese atterrito dall’uomo nero, che per avere paura si fa bastare l’ombra, che si accoscia tremante davanti ai maiali che da un giorno all’altro hanno iniziato a camminare sulle zampe posteriori. Siamo un Paese senza memoria, che occhio non vede e cuore non duole. Ed è dentro questo occhio che non vede e questo cuore che non duole che muore ogni essere umano che varca con una pena da scontare le porte di una block house.
* La riflessione è già stata pubblicata sul blog La biblioteca di Montag