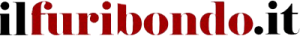di Elisabetta Viti – disegno di Giuseppe Romeo-
«Papà, papà, guarda, c’è Komòdo!» gridò il bambino indicando il nuovo cartellone pubblicitario affisso, dall’altro lato della carreggiata, di fronte alla porta aperta della pizzeria. «Non ci sono draghi in Inghilterra» commentò il padre dall’interno, senza levare gli occhi dall’impasto che stendeva rapidamente per la prima infornata del giorno. Sull’uscio si affacciò invece Estella, l’unica femmina under tredici di tutto il pezzo di strada – dalla botteguccia dei dominicani fino alle cassette di frutta dei neri – su cui il bambino aveva il permesso di giocare. «Ma è proprio lui! Allora esiste davvero, Pip! » la bambina in realtà si chiamava Zoe come la nonna paterna salutata sei mesi prima all’aeroporto di Atene, ma da quando l’anno scorso la madre, un donnone di età indefinita e di origini sicule, le aveva annunciato il trasferimento a Londra, aveva deciso di imparare l’inglese leggendo in lingua originale Grandi Speranze. Era un testo facilitato per le elementari, dove la snob Estella spiccava, in copertina, nel suo vestito vittoriano color pervinca accanto a Pip, il ragazzo in calzoni rattoppati infatuato di lei. Da qui la decisione della bambina di ribattezzare se stessa e il suo giovane amico italiano coi nomi dei protagonisti di Dickens. Pino Pip aveva ricambiato l’onore permettendo a quella femmina dai modi vagamente maschili di giocare col suo drago. E di sedere su una vecchia seggiola della pizzeria che, per far piacere a Estella, aveva chiamato “Dickens’ chair”, la “sedia di Dickens”. Col drago, Zoe si limitava in realtà a far chiacchierare la sua barbie, perché nessuno poteva tenere in mano il drago tranne Pip. Quanto all’idea di una sedia, appartenuta in passato allo scrittore e capitata chissà come proprio lì, era venuta a Pino pensando a quei ristorantini dell’entroterra calabro dove era finito due estati fa coi nonni di Reggio e dove c’era sempre qualche sgarrupato scranno di Giuseppe Garibaldi a dar pregio al locale. «Non capisco perché se siamo su un’isola non vediamo il mare» stava chiedendo in quel momento la barbie di Zoe a Komòdo, il drago di pezza di Pino. «Il mare c’è, solo che da qui non si vede». «Come l’isola del tuo drago?”. «Quella è molto più lontana, dall’altra parte dell’Oceano». Da che aveva memoria, Pino aveva sempre sognato l’isola di Komòdo, l’unico posto al mondo dove abitava la più grande lucertola esistente e ultimo discendente di una specie di varanidi scampati all’era glaciale. Pino sapeva tutto del gigante verde capace di disseppellire cadaveri umani per cibarsene e alto anche più di tre metri. A scuola ne collezionava ritagli di immagini scaricate da internet allo stesso modo con cui i suoi compagni si scambiavano figurine di dinosauri. Solo Zoe però credeva alla sua storia. Per gli altri ragazzini, e soprattutto per Lucio, Pino era solo un bambino strano che giocava con una bambina dal nome inventato e la sua barbie da femmine. E che credeva nei draghi. Lucio era il figlio di una famiglia di pugliesi che nel sobborgo a nord di Londra stavano già da due generazioni. Non ce l’aveva davvero con Pino, ma era geloso di Zoe e cercava qualunque occasione per screditare il rivale agli occhi di lei. «Figurati se do retta a un ateo.» aveva tagliato corto Zoe una mattina davanti Pino. «Come fai a sapere che è ateo?». «Pensa, non crede in Dio e nemmeno a Babbo Natale! ». «Come col mio drago? ». «Sì.». Da quel giorno Pino aveva deciso (senza dirlo) che da grande avrebbe sposato Estella e sarebbero andati a vivere insieme sull’isola di Komòdo.
II
«Sempre appresso a quel pupazzo, tuo figlio! Non parla d’altro. Questa storia non fa bene a lui come non ne ha portato a te. » nemmeno Caterina si era affacciata a guardare quando il bambino, due ore prima, aveva chiesto a suo padre di andare a vedere il drago. Ci era abituata. «Komòdo pesa settanta chili. Komòdo può uccidere un cervo con un solo colpo di coda. Komòdo vede fino a trecento metri. Komòdo, quando dorme, ha le mascelle che sorridono». «E’ solo un bambino» aveva sussurrato Corrado, guardando crescere l’ultimo impasto nella terrina «E poi che c’è di male a credere in un animale che esiste davvero? Komòdo e la sua isola non sono fantascienza». «Ma Komòdo non è solo un drago per noi» la moglie, ex studentessa di Belle Arti conosciuta a Reggio ai tempi dell’Accademia, non gli aveva mai perdonato quella fissazione che li aveva portati a fare i pizzaioli in un pidocchioso sobborgo di Londra e stava contagiando anche Pino.
Il pupazzo verde dagli occhi gialli era tutto ciò che restava di un logo di scarpe. Corrado l’aveva disegnato otto anni prima, a Reggio, per un concorso di idee per giovani creativi: il bando era stato lanciato da una grossa ditta localeche aveva deciso di espandersi nel calzaturificio e aveva acquistato a tal fine, a meno di metà prezzo, un terreno messo in vendita dal Comune durante un’asta andata quasi deserta. Il particolare che nel consiglio di amministrazione aziendale ci fosse il fratello del sindaco, già indagato per mafia, fu notato solo da una scalcinata redazione on line, subito ricoperta di insulti e minacce di querela. Ad attrarre Corrado erano gli ottomila euro promessi al vincitore: una cifra che non racimolava nemmeno con un anno di lavoro come ghost designer per “Young Fire”. Nella prima agenzia di comunicazione della città presieduta dall’avvocato del sindaco, Corrado metteva a frutto, dalle otto di mattina alle otto di sera, un costoso corso per grafici pubblicitari frequentato, subito dopo il diploma in Belle Arti, con la buonuscita del padre. «Vedrai, stavolta svolteremo amore» ripeteva più a se stesso che a Caterina, lavorando febbrilmente di notte al suo progetto. Le sue invenzioni finora avevano fatto il successo della “Young Fire”, sebbene senza la sua firma. Quel bando di scarpe era l’occasione per mostrare a tutti chi era veramente. «Tutto sta nell’ avere l’idea giusta» era stato il refrain del professor De Luca, attempato docente di corso con il vezzo degli etimi di ginnasiale memoria «E l’idea giusta, quella che trasformerà il parassita sfigato che siete ora in homo faberfortunaesuae, è un monstrum, un grosso essere prodigioso capace di spazzare via, col colpo di coda dell’ingenium, retorica e luogo comune e soffiare il fuoco sacro dell’invenzione». Il “we can” obamiano in salsa locale era apparso sulle prime a Corrado proprio quell’esempio di ovvietà che avrebbe dovuto evitare ma, a forza di sentirselo ripetere, aveva finito per associarsi in lui all’immagine del grande sauro dell’Indonesia scoperto per caso qualche mese prima, zigzagando di notte sul digitale terrestre. Il drago di Komòdo appunto. Quando era uscito il bando per il logo di scarpe, l’immagine metaforica del drago anti-retorica si era concretizzata in una originale associazione linguistica: se infatti Komòdo come drago era una parola piana, accentata sulla penultima sillaba, il rimando al suo omofono sdrucciolo, “còmodo”, era però immediato e permetteva di associare il lucertolone di Komòdo proprio ad un comodo paio di scarpe con accento sulla terzultima. In breve tempo lo schizzo del drago con le scarpe era stato abbozzato e di notte in notte si arricchiva di tutti i requisiti richiesti dal bando: layout di stampa, font, disegni vettoriali… Ma il punto di forza per Corrado era lo slogan: “Komodo, il drago delle scarpe”. Caterina, per compiacere Corrado, aveva confezionato la propria versione di stoffa del drago di Komòdo e glielo aveva fatto trovare all’alba sulla scrivania. Con ottomila euro e con la fama del progetto vinto, Corrado avrebbe ottenuto finalmente un po’ di visibilità e un diverso inquadramento dopo anni di promesse: «Continui così ragazzo e vedrà vedrà… nella vita ci vogliono idee e fede, e lei li ha, li ha» aveva ribadito ancora una settimana prima l’avvocato, firmando con soddisfazione l’ennesima trovata di quell’impiegato geniale di cui non rammentava mai il nome. Finalmente, sognava Caterina, si sarebbero sposati e aveva sognato talmente tanto che, un po’ per disattenzione un po’ per scelta, per tutto il mese in cui Corrado aveva lavorato al logo di scarpe, aveva scordato di prendere la pillola. Fu così che, tra una pausa e l’altra del disegno, non si sa se stesse nascendo il “monstrum” del professor De Luca, la grande idea capace di sbloccare le loro carriere. Di certo, proprio in quei giorni, Corrado e Caterina avevano concepito Pino.
III
«Tre pizze per i signori e due Coke»: le comande tra mezzogiorno e le due si alzavano in piccole torri che Caterina accumulava sulla penisola, tra l’asfittico forno a legna e la sala destinata agli avventori. I capelli di Corrado, ricci e neri come quelli di suo figlio, sgocciolavano piccoli cerchi di sudore sulla t-shirt bianca con la scritta “Italian Pizza” sul davanti. Tra i tavolini nichelati stonava un’unica sedia di legno con i braccioli tarlati e le gambe sghembe. «Dobbiamo toglierla da lì prima che qualche cliente ci caschi e il proprietario getti la colpa su di noi» stava osservando Caterina. Con l’arrivo dell’estate quel lavoro era ancora più faticoso e Caterina meditava da tempo di mandare Pinuccio da solo in Calabria dai nonni a prendere un po’ di sole, poi però la paura della lontananza le faceva sempre cambiare idea: «Ci pensi che Pino, a sette anni, non sa ancora nuotare? ». «Alla sedia ci penso io, non buttarla!» si raccomandò Corrado. «Tu non mi ascolti mai – Caterina sorrise ad un connazionale che gli chiedeva sempre gli orari degli autobus alla fermata più vicina– Il 9 passerà tra poco, signor Giovanni, ma se è pieno a quest’ora tira dritto. Il solito panino da portar via?Ti ricordi, Corra’, quando ti avevo detto di lasciar perdere il progetto di Komòdo ché tanto il vincitore si sapeva da prima del bando? Hai voluto continuare ed eccoci qua…». «Queste sono per il tavolo 2. E comunque quando lo hai detto, il mio progetto era quasi concluso» Corrado le stava passando le napoletane e le bibite dell’ultimo ordine. «Hai perso altre quattro settimane, duecento euro di stampa e il tuo lavoro. Yes sir, it’ll take abouttwenty minutes » Caterina sapeva che era sbagliato rinfacciare continuamente al marito il passato, ma proprio non riusciva a contenersi. «Ce li scambiamo? » la voce di Zoe echeggiò infantilmente cattiva dentro la sala, mentre Pino scacciava il pericolo di essere visto tenere in mano una barbie da femmina davanti al timore di perdere la stima della sua migliore amica. «Via di qua, bambini! Non si gioca dentro a quest’ora, disturbate i clienti! » gridò Caterina ricacciando i due piccoli in strada. Il bando era poi andato come da copione. Gli ottomila euro erano stati assegnati al figlio dell’avvocato, fresco di diploma superiore e con nessuna propensione artistica. E il progetto di Corrado rigettato per un vizio di forma. «Qui manca un codice…» aveva commentato un vecchio giurato rigirandosi tra le mani il disegno del drago. Gli altri anziani, di anagrafe e commissione, annuirono senza verificare e passarono oltre. Caterina ricordava di avere personalmente controllato e ricontrollato più volte la documentazione. Malgrado le perplessità dell’ultimo periodo, quando quei giornalisti le avevano messo in testa il sospetto della truffa, una parte di sé continuava a sperare, se non nella grande svolta immaginata da Corrado, almeno in nuovo inizio. Invece, dopo la vittoria del figlio, l’avvocato aveva lasciato a quest’ultimo la direzione della “Young Fire”, Corrado non era più riuscito a sopportare in silenzio lo sfruttamento a cui era sottoposto da anni e, a furia di rispondere a quel coetaneo raccomandato e arrogante che era ora il suo superiore, si era ritrovato licenziato. La delusione l’aveva spinto ad abbandonare la grafica e ricominciare in Inghilterra con Caterina, ormai prossima al parto, lavorando nel settore della pizza da asporto e del fast food. «Intanto la sposto in strada.» disse Caterina, spingendo fuori la vecchia sedia accanto al bidone dell’immondizia. «No signora, non farlo! Quella è la sedia di Dickens!» urlò Zoe dal bordo del marciapiede. «Sempre con queste stupidaggini, voi due!» ribatté Caterina, mentre Zoe cercava con gli occhi gli occhi Pino che li nascose nelle fenditure del lastricato «Mio figlio è come suo padre: ha troppa fantasia! Pinuccio, vuoi spiegare alla tua amica che questa non è mai stata la sedia di Dickens? ». E senza attendere seguito rientrò in pizzeria, lasciando la sedia sotto il picco del sole. «Lucio ha ragione, sei solo un bugiardo!» Zoe, con in mano il draghetto appena scambiato, ficcò sull’amico un’occhiata rabbiosa e lanciò con forza il pupazzo al centro della carreggiata. Dall’interno del locale Corrado e Caterina sentirono solo il lungo rumore dell’autobus che frenava all’improvviso. E che si fermò giusto un attimo dopo il draghetto di Komòdo e un attimo prima del corpicino di Pino, gettatosi senza guardare a raccoglierlo. Accorse solo il padre. Caterina era troppo spaventata per muoversi. Corrado toccò il bambino: era vivo. Espirò. Alzò la testa verso il conducente e fu in quel momento che notò il manifesto: il suo drago con le scarpe ammiccava, in formato gigante, dal cartellone pubblicitario affisso di fronte. Sotto c’era il nome di un nuovo marchio di calzature made in Italy: Komodo. Qualcuno in commissione doveva aver notato il suo disegno e deciso di rubarlo per venderselo. «Fucking Italians! Italiani di merda!» strillò l’autista affacciandosi tutto rosso dal finestrino. Pino era rimasto accovacciato a guardare il suo drago che moriva sotto la ruota anteriore di un classico pullman bipiano. «Vieni dentro Pinuccio: te ne costruirò un altro. Ok?» sussurrò Corrado aiutando Pino ad alzarsi. Fu allora che Pino si accorse di avere ancora in mano la barbie di Zoe. Si avvicinò alla bambina ritta in piedi, sul marciapiede, nel suo vestito color pervinca: «E nemmeno tu sei Estella» disse restituendole la bambola. Poi voltò le spalle e tornò da Corrado: «Fa niente, papà. Non mi interessa più» rispose tirandosi dietro la porta a vetri dell’ingresso «Sono grande ormai per i draghi».